|
LE
PERCOSSE DAI RIFUGIATI
|
| Home | Arte e Cultura | Immigrazione | Islam | Notizie | Cucina | Aziende | Giustizia | Suggerimenti | E - Mail |
|
LE
PERCOSSE DAI RIFUGIATI
Hanno iniziato con strette di mano. Noi dicevamo Salaam aleikum che la pace sia con te poi il primo sasso è passato vicino alla mia faccia. Un ragazzino cercava di prendere la mia borsa. Poi un altro sasso. Poi qualcuno mi ha colpito sulla schiena. Poi dei giovani hanno rotto i miei occhiali, hanno iniziato a sbattermi pietre sul viso e sulla testa. Non potevo vedere a causa del sangue che usciva dalla fronte e mi copriva gli occhi. E proprio allora, ho capito. Non li potevo biasimare per ciò che stavano facendo. In realtà, se io fossi stato nei panni dei rifugiati afgani di Kila Abdullah, vicino al confine afgano-pakistano, avrei fatto la stessa cosa a Robert Fisk. O a qualsiasi altro occidentale che avessi trovato. Allora perché documentare i miei pochi minuti di terrore e disgusto per me stesso, sotto laggressione, vicino al confine afgano, mentre sanguino e grido come un animale, quando centinaia siamo franchi, e diciamo migliaia di civili innocenti stanno morendo sotto gli attacchi aerei americani in Afghanistan, quando la Guerra per la Civiltà sta bruciando e menomando i Pashtun di Kandahar e distruggendo le loro case, perché il bene deve trionfare sul male? Alcuni degli afgani del piccolo villaggio sono lì da anni, altri sono arrivati disperati e infuriati ed in lutto per i loro cari massacrati durante le ultime due settimane. Era un brutto posto per rompere la macchina. Un brutto momento, proprio prima dellIftar, la fine del digiuno quotidiano del Ramadan. Ma ciò che è successo è simbolico dellodio, della violenza e dellipocrisia di questa sordida guerra, un branco crescente di afgani indigenti, giovani e vecchi, che hanno visto degli stranieri nemici in mezzo a loro e hanno cercato di distruggerne almeno uno. Molti di questi afgani, abbiamo appreso, si sentivano oltraggiati da ciò che hanno visto in televisione a proposito dei massacri di Mazari-Sharif, dai prigionieri uccisi con le mani legate dietro la schiena. Più tardi, un abitante del villaggio disse ad uno dei nostri autisti, che avevano visto il video degli ufficiali della CIA, Mike e Dave, che minacciavano di morte un prigioniero di Mazar inginocchiato davanti a loro. Erano illetterati dubito che molti sapessero leggere ma non serve uneducazione scolastica per reagire alla morte dei propri cari sotto le bombe di un B-52. Ad un certo punto un adolescente urlante si è rivolto al mio autista e gli ha chiesto, in tutta sincerità, Quello è Bush? Dovevano essere circa le 16.30 quando abbiamo raggiunto Kila Abdullah, a metà strada tra la città pakistana di Quetta e la città di confine Chaman; Amanullah, il nostro autista, Fayyaz Ahmed, linterprete, Justin Huggler dellIndependent fresco dalla copertura del massacro di Mazar ed io. Allinizio capimmo che qualcosa non andava, quando la macchina si fermò nel bel mezzo di una strada stretta e affollata. Un filo di vapore bianco si alzava dal cofano della nostra jeep, un rumore continuo dei clacson, degli autobus, dei camion e dei risciò che protestavano per il blocco del traffico che avevamo creato. Siamo scesi tutti e quattro e abbiamo spinto la macchina sul lato della strada. Ho mormorato qualcosa a Justin sul fatto che questo era un brutto posto per rimanere in panne. Kila Abdullah è la patria di migliaia di rifugiati afgani, masse di poveri ammucchiati uno sullaltro, che la guerra ha prodotto in Pakistan. Amanullah se ne andò per cercare unaltra macchina cè solo una cosa peggiore di una folla di uomini adirati, ed è una folla di uomini adirati quando scende il buio e Justin ed io sorridevamo alla calca, inizialmente amichevole, che si era già creata attorno al nostro veicolo fumante. Ho stretto molte mani forse avrei dovuto pensare al signor Bush e pronunciato molti Salaam aleikum. Sapevo cosa poteva accadere se i sorrisi scomparivano. La folla aumentava e suggerii a Justin di allontanarci dalla vettura, di camminare in mezzo alla strada. Un bambino mi aveva dato un colpetto abbastanza forte al polso e mi convinsi che era stato un incidente, uno scatto infantile di disprezzo. Poi un sasso passò vicino alla mia testa e rimbalzò sulla spalla di Justin. Justin si girò. I suoi occhi trasmettevano preoccupazione, e mi ricordo come respiravo. Ti prego, pensai, è solo uno scherzo. Poi un altro ragazzino cercò di prendermi la borsa. Conteneva il passaporto, carte di credito, denaro, diario, agenda, cellulare. Diedi uno strattone e misi la tracolla attorno alla spalla. Justin ed io attraversammo la strada e qualcuno mi colpì sulla schiena. Come esci da un sogno quando i personaggi improvvisamente diventano ostili? Ho visto uno degli uomini che erano tutti sorrisi quando ci stringevamo le mani. Non stava sorridendo ora. Alcuni dei ragazzi più piccoli stavano ancora sorridendo, ma le loro smorfie si stavano trasformando in qualcosaltro. Lo straniero rispettato luomo tutto salaam aleikum pochi minuti prima era sconvolto, spaventato, in fuga. LOccidente era trascinato verso il basso. Justin veniva spintonato e, in mezzo alla strada, vedemmo un autista di autobus che ci faceva dei cenni verso il suo veicolo. Fayyaz, ancora vicino alla macchina, non capiva perché ci eravamo allontanati, e non riusciva più a vederci. Justin raggiunse lautobus e salì a bordo. Quando misi il piede sul gradino tre uomini tirarono la tracolla della borsa e mi ributtarono sulla strada. Justin tirò fuori la mano. Attaccati, gridò. Così feci. Fu il momento in cui il primo schianto potente cadde sulla mia testa. Quasi crollai sotto il colpo, le mie orecchie fischiavano per limpatto. Me lo aspettavo, anche se non così doloroso, duro, non così immediato. Il suo messaggio terribile. Qualcuno mi odiava abbastanza da ferirmi. Ci furono altri due colpi, uno dietro la spalla, un forte pugno che mi mandò a sbattere sulla fiancata dellautobus, mentre ancora afferravo la mano di Justin. I passeggeri guardavano verso di me e poi verso Justin. Ma non si muovevano. Nessuno voleva aiutare. Gridai Aiutami Justin, e Justin che stava facendo più di quanto un essere umano può fare, stringendo la mia presa che si stava allentando mi chiese al di sopra delle grida della folla cosa volevo che facesse. Allora realizzai. Potevo appena sentirlo. Sì, stavano gridando. Afferrai il termine kaffir infedele? Forse mi sbagliavo. A quel punto fui strappato via da Justin. Ci furono altri due colpi sulla mia testa, uno per parte, e per qualche strana ragione una zona della mia memoria alcune piccole incrinature nel mio cervello riprodusse un momento a scuola, una scuola elementare chiamata I Cedri, nel Maidstone (distretto inglese, N.d.T.), più di 50 anni fa, quando un bambino alto, costruendo castelli di sabbia nel cortile, mi colpì sulla testa. Ebbi un ricordo del colpo come se odorasse, come se avesse colpito il naso. La botta successiva giunse da un uomo che avevo visto portare una grossa pietra nella mano destra. Me la sbatté con forza tremenda sulla fronte, e qualcosa di caldo e liquido si diffuse lungo la mia faccia, le labbra e il mento. Mi prendevano a calci. Sulla schiena, sulle tibie, sulla coscia destra. Un altro adolescente afferrò di nuovo la mia borsa ed io stavo aggrappato con la sinistra alla tracolla, alzai lo sguardo improvvisamente e realizzai che dovevano esserci circa 60 uomini urlanti di fronte a me. Stranamente, non era paura ciò che provai, ma una sorta di stupore. Quindi ecco come è accaduto. Sapevo che dovevo reagire. O, così ragionavo nello stordimento, sarei morto. Lunica cosa che mi sconvolse era la sensazione fisica del crollo, la consapevolezza crescente del liquido che iniziava a coprirmi. Non credo di aver mai visto così tanto sangue prima. Per un secondo colsi con lo sguardo qualcosa di terribile, un viso da incubo il mio riflesso nel vetro dellautobus, striato di sangue, le mie mani fradice come quelle di Lady Macbeth, il sangue si spandeva lungo il maglione ed il colletto della camicia, finché la schiena non fu umida e la borsa gocciolante, con schizzi cremisi che apparivano sui pantaloni. Più sanguinavo, più la folla si concentrava e mi picchiava con i pugni. Sassi e ciottoli iniziarono a rimbalzare sulla mia testa e sulle spalle. Quanto tempo, mi ricordo di aver pensato, potrà durare tutto questo? La mia testa fu improvvisamente colpita da pietre su entrambe le parti e contemporaneamente non venivano lanciate, ma usate direttamente dagli uomini che cercavano di schiacciarmi il cranio. Poi un pugno mi colpì in faccia, spaccandomi gli occhiali sul naso, unaltra mano si attaccò al paio di ricambio che avevo al collo e strappò il contenitore dalla cordicella. Credo che a questo punto dovrei ringraziare il Libano. Per 25 anni ho coperto le guerre di quel paese ed i libanesi erano soliti insegnarmi, in continuazione, come restare vivo: prendi una decisione qualsiasi decisione ma non fare nulla. Così strappai la borsa dalle mani del giovane che la teneva. Indietreggiò. Poi mi girai verso luomo alla mia destra, quello che teneva la pietra insanguinata, e gli tirai un pugno sulla bocca. Non potevo vedere molto non solo i miei occhi erano senza occhiali, ma erano annebbiati da un velo rosso vidi comunque luomo quasi tossire, un dente cadere e poi anche lui cadde sulla strada. Per un secondo la folla si fermò. Poi mi mossi verso laltro uomo, trattenendo la borsa sotto il braccio e scagliandogli un pugno sul naso. Gridò di rabbia e diventò tutto rosso. Mancai un altro uomo con un pugno, ne colpii ancora uno sul viso e scappai. Ero di nuovo in mezzo alla strada, ma non riuscivo a vedere. Mi portai le mani agli occhi, erano pieni di sangue e con le dita cercai di tirare via quella roba appiccicosa. Fece un rumore come di risucchio, ma ricominciai a vedere e realizzai che stavo piangendo e le lacrime ripulivano gli occhi dal sangue. Cosa ho fatto, continuavo a chiedermi? Ho preso a pugni ed attaccato dei rifugiati afgani, proprio la gente di cui sto scrivendo da tanto tempo, proprio quella gente mutilata e depredata, che il mio paese tra gli altri sta uccidendo, insieme ai talebani, appena al di là del confine. Che Dio mi perdoni, pensai. Credo che in effetti lo dissi. Gli uomini le cui famiglie erano uccise dai nostri bombardieri, erano ora anche miei nemici. Poi accadde qualcosa di straordinario. Un uomo venne verso di me, con molta calma, mi prese per un braccio. Non potevo vederlo molto bene a causa del sangue che mi colava sugli occhi, ma ricordo che era vestito con una specie di veste, aveva un turbante e la barba brizzolata. Mi condusse lontano dalla folla. Guardai dietro le mie spalle. Ora cerano un centinaio di uomini dietro di me e alcune pietre rimbalzavano sulla strada, ma non erano dirette a me presumibilmente per evitare di colpire lo sconosciuto. Sembrava una figura dellAntico Testamento, o una qualche storia della Bibbia, il Buon Samaritano, un musulmano forse un mullah del villaggio che cercava di salvarmi la vita. Mi spinse nel retro di un furgone della polizia. Ma i poliziotti non si mossero. Erano terrorizzati. Aiutatemi, continuavo a gridare attraverso la finestrella sul retro della cabina, le mie mani lasciavano strisce di sangue sul vetro. Guidarono per alcuni metri e si fermarono finché luomo non parlò loro di nuovo. Poi si spostarono di altri 300 metri. E lì, accanto alla strada, cera un convoglio della Mezzaluna Rossa. La folla era ancora dietro di noi. Ma due dei sanitari mi spinsero dietro uno dei loro mezzi, versarono acqua sulle mani e sul viso ed iniziarono mettere delle bende sulla mia testa, sul viso e la nuca. Sdraiati e ti copriremo con una coperta, così non ti possono vedere, disse uno di loro. Erano entrambi musulmani, del Bangladesh, ed i loro nomi andrebbero ricordati, poiché erano delle brave e sincere persone: Mohamed Abdul Halim e Sikder Mokaddes Ahmed. Sono sdraiato in terra, mi lamento e comprendo che potrò vivere. Entro alcuni minuti arrivò Justin. Lo ha protetto un massiccio soldato delle truppe del Baluchistan vero fantasma dellImpero britannico che, con un solo fucile, ha tenuto la folla lontana dalla vettura in cui sedeva Justin. Frugai nella mia borsa. Non hanno avuto la borsa, continuavo a dirmi, come se il passaporto e le carte di credito fossero una sorta di Sacro Graal. Ma si sono impossessati del mio ultimo paio di occhiali di riserva ero cieco senza tutti e tre mancava il cellulare e anche lagenda, contenente 25 anni di numeri telefonici di tutto il Medio Oriente. Cosa dovevo fare? Chiedere a chiunque mi abbia mai conosciuto di rinviarmi i numeri di telefono? Maledizione, dissi cercando di tirare un pugno e realizzando che sanguinavo da una grossa ferita sul polso il segno del dente che avevo appena tirato giù dalla mascella di un uomo, un uomo sinceramente innocente, il cui unico crimine era di essere una vittima del mondo. Ho passato più di due decenni e mezzo denunciando le umiliazioni e le miserie dei musulmani nel mondo, e ora la loro rabbia ha afferrato anche me. O no? Cerano Mohamed e Sikder della Mezzaluna Rossa, e Fayyaz che arrivò ansante dietro la macchina, furente per il trattamento riservatoci e Amanullah che ci invitò a casa sua per curarci. E cera il santo musulmano che mi prese per un braccio. E realizzai cerano tutti gli uomini ed i ragazzi afgani che mi hanno attaccato, che non avrebbero dovuto farlo, ma la cui brutalità era interamente prodotta da altri, da noi noi che abbiamo armato la loro lotta contro i russi e abbiamo ignorato il loro dolore e ridicolizzato la loro guerra civile, e poi li abbiamo armati e pagati di nuovo per la Guerra per la Civiltà, a sole poche miglia di distanza, e poi abbiamo bombardato le loro case, squarciato le loro famiglie e li abbiamo definiti danni collaterali. Così ho pensato che avrei dovuto scrivere che cosa ci è successo in questo spaventoso, stupido, sanguinoso, minuscolo incidente. Temevo che altre versioni avrebbero prodotto un racconto diverso su come un giornalista inglese fosse stato picchiato da una folla di rifugiati afgani. E naturalmente, questo è il punto. La gente che è stata assaltata sono gli afgani, gli sfregi sono stati inflitti da noi dai B-52, non da loro. E lo dirò di nuovo. Se fossi stato un rifugiato afgano di Kila Abdullah, avrei fatto ciò che hanno fatto loro. Avrei attaccato Robert Fisk. O qualsiasi altro occidentale che avessi potuto trovare. Di Robert Fisk. Pubblicato
in "The Independent" (U.K.) lunedì, 10 dicembre 2001 . |
|
|
 |
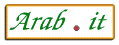
| Copyright © A
R C O SERVICE 1997-2002. All rights reserved. Tutti i diritti
riservati. E-mail: info@arab.it Tel: + 39 010 5702411 |
